Mostra

Ancora una mostra su Picasso? Anzi due? A Milano, dopo quella del Mudec - della quale s’era parlato su questo foglio lo scorso giugno. E a Mantova. Ma c’era bisogno? Sì, perché Picasso lo straniero, a Palazzo Reale fino al 2 febbraio 2025, prodotta dal Comune di Milano e Marsilio Arte, curata da Annie Cohen-Solal, non è solo una mostra su Picasso. È la mostra del Picasso migrante e malaccetto a Parigi, dunque una mostra politica e attualissima. Già. Tutti, o quasi, pensano a Picasso come a uno spagnolo divenuto francese, ed invece… “Come è possibile! Il più celebre pittore francese non è francese!” Nescit vox missa reverti, parole “dal sen fuggite” allo storico Benjamin Store nel 2021, in occasione dell’apertura parigina della mostra. Lo ricorda Cécile Debray, presidente del Musée national Picasso-Paris, che ha fornito la quasi totalità delle opere esposte.
Pittura, scultura, disegno, incisione, e poi ceramica collage, assemblage: Picasso non è classificabile, si sa, ma sono proprio versatilità nell’uso dei materiali ed eclettismo ad additarlo come sospetto, specie all’occhio vigile delle istituzioni francesi. L’artista è a Parigi la prima volta nel 1900, ha già un’opera presente all’Esposizione Universale ma frequenta i catalani, di cui molti sono anarchici e dunque, per la proprietà transitiva, è visto come anarchico pure lui, tant’è che viene schedato quando torna l’anno seguente. I viaggi e le residenze del 1902/3, quindi del 1904, al Bateau-Lavoir, son vissuti in una miseria - si veda il Portrait d’homme in mostra - che ne tempra la fibra e gli inocula gli anticorpi che lo renderanno protagonista carismatico proprio in quella Parigi che lo apprezza come artista e lo mortifica come uomo: un’inquietante ambivalenza che gli peserà a lungo. Cohen-Solal mette in rilievo le tre stigmate - così le definisce - che si palesano in quei soggiorni parigini, ma che accompagneranno Picasso per oltre quarant’anni della sua presenza nella ville lumiére: straniero, uomo di estrema sinistra - anarchico con gli anarchici catalani, poi repubblicano durante la Guerra civile di Spagna, infine comunista - ed artista d’avanguardia. Sempre anomalo, discriminato da un modo di pensare che esclude tutto ciò che non è governato dal bon ton e dall’ipocrisia borghese. Borghesia e nobiltà che tuttavia non esitano a strizzargli l’occhio. C’è negli anni successivi il Picasso che gioca con i surrealisti, lo stregone, sciamano, “Mercurio mascherato” dice sempre Cohen-Solal. Proprio come un altro stregone in musica, presentatogli da Diaghilev, Igor Stravinskij, pure lui straordinario metabolizzatore di stili, e “straniero” ma più “stratega”, dunque capace, lui sì, di ottenere nel ’34 la cittadinanza francese. Picasso vi collabora per il balletto Pulcinella, mentre Parade e Mercure sono i titoli come scenografo per Satie, mentore il conte Étienne de Beaumont. Intanto la polizia controlla, e con lei l’Académie des Beaux-Arts, altra polizia “estetico/critica”.
In mezzo a tutto ciò le opere in mostra: la candela che illumina il volto ne La Mort de Casagemas, spettro cromatico al modo puntillista già sperimentato da Seurat, ma precedente una decina d’anni la tecnica del boccioniano Rissa in Galleria. Successive le prove coeve alle Demoiselles (rifiutato dal Louvre nel ’29): Buste, Mère et enfant, lo splendido Sacré-Coeur, un tocco neoclassico nella Nature morte del ’19, la Grande bagneuse au libre. Opere del museo parigino che è sempre bello rivedere. Non mancano le foto di Dora Maar sull’“in fieri” di Guernica. E poi disegni, bronzi, il corredo fotografico. Non i Saltimbanchi, che non possono lasciare Washington e la cui un po’ ingannevole (agli sprovveduti) riproduzione sta sul passaggio, ma due coeve (1905) puntesecche e un disegno sullo stesso tema. Nel vederli viene in mente l’infinita tristezza dei Retirantes, i migranti del Sertão nordestino del brasiliano Candido Portinari. Sia pur quarant'anni dopo quelle incisioni, è carico della stessa desolazione, ma a differenza di Portinari ciò che arriva delle opere realizzate da Picasso in quegli anni non è la “compassione”, l’afflato universalistico bensì lo stato di indigenza dell’artista, dunque la testimonianza di una condizione individuale. Sarà di tempi a venire la sensibilità politica, la denuncia. Le citate stigmate s’inquadrano nel rifiuto degli stranieri nella Francia fra due guerre. Obiettivo principale i tedeschi, come ad esempio il mercante di Picasso Daniel-Henri Kahnweiler, per giunta ebreo d’origine. Allo scoppio della Grande Guerra finiranno sotto sequestro ben 700 opere cubiste, danneggiando Picasso al punto che Cohen-Solal definirà il pittore “vittima collaterale del nazionalismo francese”. Fino al ’47 le sue opere saranno escluse alle collezioni pubbliche francesi. Senza dire che all’epoca del citato sequestro lo stato francese si guardò bene dall’esercitare il diritto di prelazione sulle opere di Kahnweiler messe in asta. Un disinteresse cui fa da contraltare l’entusiasmo di Alfred Barr Jr, che inaugura il MoMA proprio nel nome di Picasso, marcando una ricezione che renderà il maestro spagnolo fin dagli anni ’30 universalmente riconosciuto.
L’ideale rapporto Picasso/Cohen-Solal non finisce qui. Fino al 6 gennaio a Mantova, Palazzo Te, Picasso. Poesia e Salvezza. Qui alla curatrice s’affianca Johan Popelard. Naturalmente la fa da padrone il tema delle metamorfosi, con incisioni pensate in dialogo con Ovidio e Giulio Romano, e occasioni per riflettere ancora sul tema del rifiuto dello straniero. Si scopre anche il Picasso autore di poesie: 340, scritte fra il ’35 e il ’59, ruvide, sin truculente.
Milano/Mantova: intrapresa impegnativa, ricco e articolato allestimento che apre uno sguardo inedito su Picasso. Visite che val la pena accompagnare con la lettura del libro di Annie Cohen-Solal.
Lettere, documenti e aspetti inediti nel catalogo
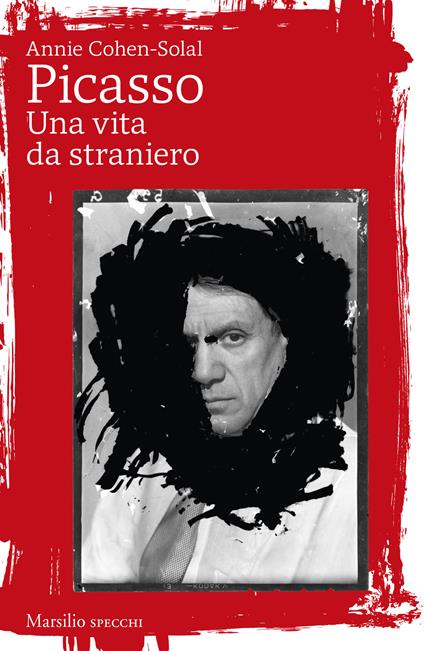
Se l’autrice del libro è la curatrice della mostra che porta quasi lo stesso titolo, risulta inevitabile immaginare una sorta di osmosi fra le due cose. Picasso - una vita da straniero, di Annie Cohen-Solal è dell’esposizione milanese un vero compagno di viaggio. Uscito in aprile nella traduzione di Manuela Bertone, sempre per Marsilio (collana Specchi), il libro arriva in Italia a tre anni dalla prima edizione e con un successo internazionale. La narrazione si snoda per episodi e personaggi raccontati. Valga ad esempio il rapporto con la madre Maria, con cui l’artista intrattiene uno scambio epistolare dal 1904 al ’38, anno della morte di lei. Lettere che, scrive Cohen-Solal, “possiedono una bellezza che ammalia, lieve e musicale come il Cantico dei cantici”. Documenti di una vicenda familiare di cui, sostiene l’autrice, nessuno aveva mai tenuto conto. Rara la capacità di far interagire con leggerezza la narrazione con il carico di informazioni acquisite e riportate con acribia. Cohen-Solal riesce a regalarci aspetti inediti di una delle figure del Novecento più studiate, chiacchierate, mitizzate. E, proprio come avviene per la mostra, di grande attualità nell’inquadrare la dolorosa vicenda dell’iberico non accettato in terra francese. Piace il déplacement fra il racconto storico e quello sulle esperienze della stessa autrice, il suo lavoro sulle fonti, portato avanti in biblioteche e archivi. “Successivamente, in quattro tappe - scenografo dei Ballets Russes e dei balli mondani Beaumont, poi artista stregone vicino ai surrealisti, in seguito scultore e Minotauro nella sua tenuta di Boisgeloup, e infine pittore politico impegnato con gli immigrati spagnoli -, Picasso continua a muoversi a modo suo tra la cerchia degli esuli e quella degli spaesati”. Parole che lasciano intravvedere l’inquieto polistilismo picassiano come proiezione fantastica d’una sorta di ansia esistenziale, premessa ed insieme conseguenza dello stato di déraciné, fungendo altresì da condizione, certo sofferta ma ideale, per affermarsi in maniera pervasiva, come forse mai s’è dato finora di osservare. Non si temano dunque le oltre seicento pagine (di cui un centinaio di note e apparati), a fronte di una lettura godibilissima.
© Riproduzione riservata
Gazzetta di Parma Srl - P.I. 02361510346 - Codice SDI: M5UXCR1
© Gazzetta di Parma - Riproduzione riservata