un grande parmense dimenticato

Ermanno Stradelli, primo dei sette figli del conte Francesco Stradelli e della contessa Mariana Douglas Scotti di Vigoleno, nacque a Borgo Val di Taro l’8 dicembre 1852; studiò giurisprudenza all’Università di Siena e, dal 1875, all’Università di Pisa, ma non concluse gli studi, deciso a dedicarsi all’esplorazione dei Paesi «selvaggi».
Desiderava l’Africa ma, per l’opposizione della madre, decise per l’America Latina; arrivò a Manaus nel 1879; vi si fermò presso i padri francescani, che vi avevano una missione, per ambientarsi e migliorarsi nella lingua portoghese.
Iniziò a percorrere i fiumi, su fragili ubá [canoe scavate in un tronco]; né un naufragio sul fiume Purus, in cui perse tutta la sua attrezzatura, né la malaria, contratta lungo il fiume Juruà mentre studiava il modo di estrazione del lattice dall’albero della gomma, lo scoraggiarono.
Percorse parte del fiume Uaupés e di suoi affluenti; si unì ai lavori della Commissione brasiliana sui limiti con il Venezuela, visitando regioni inesplorate e raccogliendo appunti linguistici, etnografici, naturalistici (flora e fauna), topografici.
Nel 1884 partecipò alla Missione per la pacificazione della Crixanàs guidata da João Barbosa Rodrigues, sul fiume Jauaperi (29 marzo-17 aprile), riprendendo fotografie alcune delle quali sono conservate, a Roma, presso la Società Geografica Italiana; in estate rientrò in Italia.
Nel biennio seguente, completò gli studi all’Università di Pisa e, intanto, pubblicò Eiara. Leggenda Tupi-Guaranì la cui presentazione è datata Pisa, 28 aprile 1885, ma il testo è da Samouma (Juruà) 21 marzo 1881.
«Eiara – annotava – è uno dei principali miti della limitata teogonia Tupi-Guaranì. Il suo significato letterale sarebbe signora delle acque (da Y acqua, iara signore)»; nello stesso anno uscì a stampa la traduzione del poema di Domingos José Gonçalves de Magalhães, intitolato La confederazione dei Tamoi in cui si narra un episodio della lotta degli indios contro i colonizzatori, traduzione che aveva compiuto durante l’ozio forzato seguito al naufragio del 1880; «La Confederazione dei Tamoi - scrisse - appartiene a quelle opere che, marcando un periodo nella storia letteraria di un popolo, è patrimonio universale».
Nel 1886 partecipò al Congresso degli Americanisti a Torino con un contributo sui petroglifi amazzonici che egli, percorrendo gli affluenti del Rio Negro, aveva cominciato a scoprire e a rilevare.
Nel dicembre, si laureò in giurisprudenza ed iniziò ad esercitare la professione forense presso uno studio legale di Genova; vi conobbe, però, il marchese Augusto Serra e decise di intraprendere con lui una spedizione per scoprire le sorgenti dell’Orinoco.
All’inizio del 1887 partì, da solo, per il Venezuela, con l’intesa che Serra lo avrebbe raggiunto di lì a poco; dopo essere stato ricevuto, a Caracas, dal Presidente della Repubblica, iniziò la risalita dell’Orinoco, riferendone puntualmente al Bollettino della Società Geografica Italiana; il 21 agosto doveva, però, scrivere da Porto Samuro (Atures): «Dalle ultime lettere d’Italia sono ormai sicuro che Serra non viene. A Manaos dunque, perché è là che anderò».
Rinunciato a cercare le sorgenti, nel proseguire il viaggio, compì una lunga esplorazione del corso del fiume Vichada, affluente di sinistra dell’Orinoco, tracciandone una mappa e raccogliendo numerose informazioni sulla popolazione dei Guahibo di cui riprodusse minuziosamente capanne, armi, suppellettili, ornamenti; pubblicò, in seguito, Appunti di lingua Tamo o Guahibo del rio Vichada.
Giunse, a fine anno, al passaggio dal bacino dell’Orinoco a quello del Rio Negro e, il 24 febbraio 1888, a Manaus.
Poco dopo fu invitato ad una missione nel Rio Branco; il 5 giugno giunse a Boa Vista, oggi città di 400.000 abitanti e capitale dello Stato di Roraima che, allora, aveva 27 case «tra cui una di pietra, appartenente al signor Baroni [un migrante italiano vi era già arrivato!], e in breve avrà una chiesa, essa pure in pietra».
Nello stesso anno e nel successivo percorse diversi fiumi e visitò alcune malocas (grandi capanne di abitazione collettiva) degli Apuriná, realizzando un resoconto fotografico.
Nel 1890-1891 compì la terza spedizione sul fiume Uaupés, insieme a Maximiano José Roberto, un ricercatore indigeno; avendo conquistato la fiducia di un tuxaua [capo tribù] che gli aveva rivelato il segreto, riuscì, per primo, a decifrare i simboli raffigurati nei petroglifi rinvenuti sulle rive del fiume Uaupés, vicino a Jauareté; pubblicò, inoltre, sul Bollettino della Società Geografica Italiana, La leggenda dell’Jurupary, lungo, complesso, fondamentale racconto della mitologia amerindia.
Nel 1892 espose la collezione etnografica ricavata dalla spedizione nello Uaupés a Rio de Janeiro, nel Museo Nazionale. Parte della raccolta venne inviata a Genova, per l’Esposizione delle Missione Cattoliche Americane nel 400° della scoperta dell’America; i cimeli, con i loro cartellini esplicativi ancora attaccati, sono visibili, conservati dal conte Orazio Zanardi Landi, discendente da una delle sorelle Stradelli, nel castello di Rivalta, sulla riva del Trebbia, presso Piacenza.
Nel 1893 ottenne la cittadinanza brasiliana e, nel 1894, la licenza di advogado provisionado; di conseguenza, nel 1895 fu nominato Pubblico Ministero del secondo distretto di Manaus e poi trasferito, con lo stesso incarico, a Làbrea, sul fiume Purus, 700 km (in linea d’aria) a Sud-Ovest; nel 1896 passò a Maués, 250 km ad Est di Manaus e, successivamente, a Canutama, sul rio Purus, non lontana da Làbrea, dove terminò di scrivere il poemetto Pitiàpo, in portoghese, firmandone la prefazione in data 16 novembre 1896; nello stesso anno pubblicò, sul Bollettino, le Leggende del Taria.
Nel 1897 venne in Italia per proporre a Giovan Battista Pirelli la formazione di un trust italo-brasiliano per la produzione della gomma, settore nel quale dominavano società anglo-americane che sfruttavano in modo disumano gli indigeni dell’Amazzonia; purtroppo, il suo incontro non raggiunse l’obiettivo sperato.
Nel 1898-1899 pubblicò a puntate, sul Correio do Purus, il poemetto Ajuricaba, in portoghese; compì un viaggio in Italia con una nave della compagnia La Ligure Brasiliana, che tra il 1897 e il 1903, gestì una linea regolare tra Manaus e Genova, e vi ritornò, probabilmente per l’ultima volta, nel 1901; pubblicò, a Piacenza, in un volumetto, Duas lendas amazonicas (Pitiàpo e Ajuricaba).
Nel 1901, la sua Carta geografica dello Stato di Amazonas venne acquistata dal governo dello Stato.
Nel 1902 scelse di vivere a Tefé, circa 500 km a Ovest di Manaus, alla confluenza del rio Tefé nel rio delle Amazzoni; iniziò la costruzione della casa dove avrebbe vissuto fino alla fine del 1923, posta in una proprietà della Congregazione dello Spirito Santo, missionari cattolici; nel 1912 vi avrebbe assunto l’incarico di Pubblico Ministero ad interim.
Nel 1903 fece parte di una commissione di esperti costituita per difendere le tesi del governo brasiliano in una controversia con l’Inghilterra relativa ad un vasto territorio posto tra lo stato di Roraima e la Guyana britannica.
Nel 1904 partecipò, a Rio de Janeiro, ad una seduta della Società Brasiliana di Geografia, di cui era membro corrispondente; nel mese di maggio prese parte ad un’escursione nell’Alto Rio Branco organizzata dal Governatore; nel volume che ne fu tratto, fu inserita la cartografia del bacino del Rio Branco da lui curata. La sua collezione etnografica fu acquisita dal Governo dell’Amazzonia ed esposta nel padiglione brasiliano dell’Esposizione Internazionale di Saint-Louis.
Nel giugno del 1905 partecipò, a Rio de Janeiro, al Terzo Congresso Scientifico Latinoamericano con un contributo sulle lingue indigene della «famiglia» Tucano; negli atti, pubblicati nel 1910, furono inclusi i suoi Pequenos vocabulário. Grupos de língua tucana. Contibução para o estudo das línguas indígenas.
Fra il 1916 e il 1924 pubblicò numerosi contributi sulla Revista de Direito Civil, Commercial e Criminal occupandosi di diritto commerciale; nel 1920, completò, a Tefé, il Vocabulário português-nheengatu e nheengatu-português. Cercò, senza successo, un editore per pubblicarlo; perciò, nel 1922, fece consegnare il manoscritto all’Instituto Histórico Geogràfico Brasileiro, a Rio de Janeiro. Soltanto dopo la sua morte, nel 1929, il Vocabulário fu inserito in un fascicolo della Revista dell’Istituto; nel 2014 l’editore AE Ateliê editorial di San Paolo, lo ha pubblicato, in un volume di 536 pagine.
La versione italiano-nheengatu e viceversa, dattiloscritta, inedita, è conservata presso la sede della Società Geografica.
Nel 1925 lasciò Tefé, con l’intenzione di ritornare in Italia; giunse a Manaus col piroscafo Rio Aripuranà ma non poté soggiornare negli alberghi, né imbarcarsi sulla nave che avrebbe dovuto portarlo in patria, nonostante fosse in possesso del biglietto di viaggio, inviatogli dal fratello Alfonso, gesuita, con cui aveva sempre mantenuto i contatti, perché affetto da lebbra; fu ricoverato nel lebbrosario di Umirizal, presso Manaus, dove morì il 21 marzo 1926.
«Stradelli - ha scritto Antonio Loureiro - è stato un martire del suo idealismo. Spero che Stradelli sia nel cielo stellato insieme a Ceuci e Jurupari. Fu sepolto in una fossa poco profonda nel cimitero di Umirisal. Anni dopo, alcuni intellettuali di Manaus piantarono una rozza croce sulla sua tomba. Di questa tomba e del lebbrosario di Umirizal, con il suo cimitero, non è rimasta traccia, avidamente inghiottiti dall’espansione urbana di Manaus, ma la triste storia di Stradelli e il suo contributo agli studi sui popoli americani perdura ancora, rattristando i cuori qui e all’estero».
Dieci anni dopo la morte, un antropologo brasiliano, Luís Da Câmara Cascudo, ne pubblicò una biografia; scrisse: «Si sente, in tutti i suoi lavori, la gioia profonda prodotta dal contatto, la soddisfazione spirituale della conoscenza, cercata non per esibirla, ma per l’appagamento derivante dal legame con il misterioso passato di quella strana gente che amava illimitatamente.
In questo breve saggio – sottolineava – non è possibile precisare per quali oscure e incomprensibili ragioni, Stradelli, un signore latino, educato nella civile Piacenza, avesse raggiunto un adattamento totale, completo, assorbente, con la vita degli ameraba [lo stesso che amerindi] dei fiumi amazzonici e perché, da lì in avanti, vivesse sempre con loro fuori e dentro le malocas, ma sempre con lo sguardo illuminato da una luce che diede a lui, come a nessun altro, la capacità di individuarne lo spessore e misurarne la densità».
Corrado Truffelli
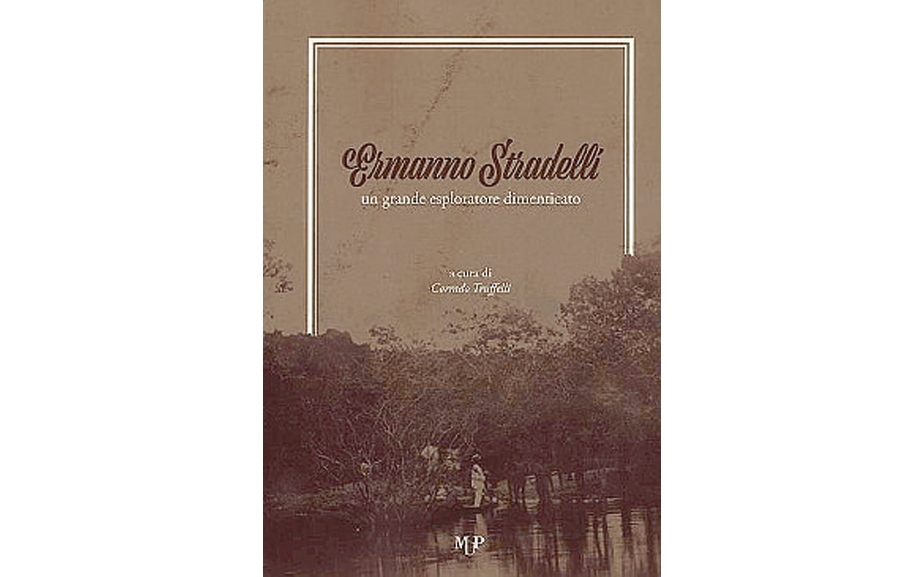
Esploratore, geografo, antropologo, letterato, politico. C'è tanto da raccontare su questo grande uomo di origini parmensi innamorato dell'Amazzonia e delle popolazioni autoctone, di cui ha documentato cultura, abitudini, miti, tradizioni senza pregiudizi né condizionamenti culturali. Lo ha fatto Corrado Truffelli nel libro «Ermanno Stradelli, un grande esploratore dimenticato» edito da Mup.
© Riproduzione riservata
Gazzetta di Parma Srl - P.I. 02361510346 - Codice SDI: M5UXCR1
© Gazzetta di Parma - Riproduzione riservata